Addio alle planimetrie e ai progetti su carta: alla XII edizione Biennale i padiglioni delle varie nazioni hanno indetto la gara a chi "lo fa più strano", e le archistar giocano a fare gli artisti concettuali
di Chiara Di Stefano

Vacant NL, where architecture meets ideas è il progetto presentato al Padiglione dei Paesi Bassi dallo studio Rietvelt Landscape. Una rappresentazione visitabile di tutti gli edifici vuoti e riutilizzabili presenti in Olanda
Il lungo percorso comincia all’Arsenale. Lo spazio centrale curato quest’anno dall’architetto Kazuyo Sejima appare lontano dall’idea che i profani possono essersi fatti della Biennale di Architettura. Una sensazione di già visto non appena si palesa di fronte il neon di ingresso, troppo simile a quello di una delle passate biennali di arti visive. Passata un’ampia stanza allestita in modo scarno e sbarrata da un enorme monolite ci si ritrova a passeggiare per i corridoi, pensando di lì a poco di trovarsi faccia a faccia con qualche progetto su carta o con qualche plastico.
Invece poco dopo si entra in una stanza apparentemente vuota, quella curata dallo studio giapponese junya.ishigami+associates, vincitori del Leone D'oro. L’impalpabile essenza dei reticoli bianchi che si intrecciano e riempiono la sala senza occuparla sarà anche suggestiva, ma alla vista appare solo come una serie di fuscelli spezzati. La realtà - scoperta grazie ad alcuni blog e non certo dalle indicazioni sul posto - è che la struttura, all’origine un reticolo verticale, si è rotta durante l’opening e al 3 settembre, giorno della nostra visita, non è ancora stata rimessa in piedi.

E c’è aria lagunare anche nel lavoro di Olafur Eliasson, dove alcune pompe d’acqua si muovono e, con forza della pressione, girano vorticosamente al buio, illuminate da luci stroboscopiche e da lampade di Wood. Più in là si trova la stanza dedicata al critico e curatore Hans Ulrich Obrist: un centinaio di schermi ritrasmette tutti i colloqui in video del celebre “intervistatore seriale”.
Il tentativo di renderla appetibile ai non addetti ai lavori - soprattutto nell’allestimento, dove si tenta il tutto per tutto - rende la Biennale di architettura quasi una brutta copia della sua sorella dedicata alle arti visive. Così nel padiglione belga si presentano appesi al muro o posizionati in centro sala dei resti di pavimenti segnati da tappeti e banchine d’aspetto della metropolitana segnate dal tempo, forse più adatti ad una rassegna di arte povera.
Continuando all’insegna del trend “tutto ciò che non sembra architettura va inserito alla Biennale Architettura” ecco dunque una carrellata di meriti e demeriti dai padiglioni delle diverse nazioni. I Paesi scandinavi presentano una vera e propria performance. Ogni settimana uno studio o un architetto differente si metterà in gioco di persona, vivendo le ore di lavoro all’interno della sede espositiva e dialogando con il pubblico. A questa pauperistica scelta dei nordici si contrappone quella del Padiglione australiano, che si butta su un allestimento da migliaia di euro proponendo due video in 3D sul riscaldamento globale e l’evoluzione dell’urbanizzazione nelle aree dell'Oceania: il tutto in una sala scurissima, illuminata appena da neon arancione.
Le parole d’ordine da questo punto della mostra in poi saranno solo due: tecnologia ed ecosostenibilità. Su questa linea è efficace il confronto tra un Padiglione greco che presenta una sorta di arca della salvezza (all’interno della quale si può trovare di tutto, anche funghi allucinogeni) e la proposta austriaca: alcuni progetti dell'archistar Zaha Hadid mostrati su tre nuovissimi iPad.
In Canada scelgono invece la via dell’installazione interattiva, con una foresta incantata di piante-automi che, sollecitate dal visitatore, si muovono in uno scenario lugubre e fantastico. Una menzione di riguardo, legata forse più al design che all’architettura, è per il Padiglione serbo dove gli architetti artisti hanno inventato dei trabiccoli a ruote per portarci dietro le nostre piante preferite. Il peggio invece lo danno i russi, che inspiegabilmente ci avvolgono in un trompe l’oeil che occupa tutta la parete di una sala circolare con porte a scatto.
Infine il Padiglione ungherese, ad offrire un tocco di paradossale ironia alla rassegna, presenta centinaia di matite che pendono dal soffitto - matite che dovrebbero servire a tracciare i progetti e le planimetrie delle quali ogni padiglione è sprovvisto.
Proprio quando non si spera più di trovare l’architettura che si cercava, però, arriva l’illuminazione: il Padiglione Italia, in fondo allo spazio Arsenale. Uno spazio bello, intenso, proteso verso il futuro, dove tecnologia e ecologia si incontrano. AILATI è il titolo del concept ideato da Luca Molinari: guardarsi allo specchio per capire da dove veniamo e dove stiamo andando. La mostra qui è suddivisa in tre sezioni: Amnesia nel presente. Italia 1990-2010 propone un bilancio dello stato dell’architettura italiana, Laboratorio Italia (dove vengono mostrate le ultime proposte per un’architettura vicina ai bisogni delle persone, tra le quali colpisce la sezione Abitare sotto i 1000 euro al mq), e Italia 2050 visionario progetto che unisce multimedialità e creatività, realizzato in collaborazione con la rivista di alta tecnologia Wired.

Tags: Architettura, Biennale di Venezia, Chiara Di Stefano, Hans Ulrich Obrist, Kazuyo Sejima, mostra recensione, Padiglione Italia,
XII Mostra internazionale di Architettura, Palazzi dell'Arsenale e Giardini, Venezia
Fino al: 21 novembre
Orari: dalle 10 alle 18. Giardini chiuso il lunedì (escluso lunedì 15 novembre 2010)
Arsenale chiuso il martedì (escluso martedì 16 novembre 2010)
Ingresso: 20 Euro, Ridotto 16 Euro, Studenti e Under-26 12 Euro
Per acquistare il biglietto on-line e altre informazioni: www.labiennale.org




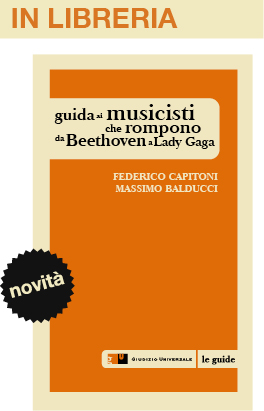



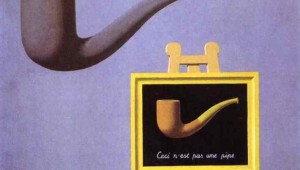



Commenti
La XII Biennale di
La XII Biennale di Architettura non è una brutta copia della sua sorella perchè non parla di arte, ma parla profondamente di architettura e dei suoi aspetti fondativi. Sicuramente lo fa in altre forme, che la rendono più difficile da comprendere e più facile da fraintendere ai "non addetti ai lavori". E' questa difatti l'ambiziosa scommessa del brillante curatore: quella di non riempire banalmente la mostra di planimetrie, progetti su carta e qualche plastico; altresì quella di lavorare direttamente sullo spazio-contenitore strizzando sicuramente l'occhio alle espressioni artistiche, sempre comunque finalizzandole alla comunicazione di temi di architettura. Il tutto è riconducibile al titolo stesso della mostra:"people meet architecture", intendendo con esso la volontà di porre il visitatore all'interno e di conseguenza in stretto rapporto con lo spazio architettonico. Idea che viene splendidamente resa dal filmato iniziale di Wim Wenders, che molti visitatori probabilmente presi dalla voglia di cercare qualche plastico avranno saltato. Il padiglione belga è poi quello che esprime al meglio il tema di questa biennale. L'allestimento gioca con le espressioni artistiche, collocando i pezzi esposti come delle opere d'arte. In realtà non ci troviamo assolutamente di fronte ad una mostra di arte povera. Difatti gli oggetti esposti non hanno alcun valore artistico ma unicamente architettonico, e ci vogliono raccontare come "la gente incontra l'architettura" e come entra in contatto fisico con lo spazio architettonico mutandolo ed arricchendolo attraverso il suo utilizzo quotidiano. Auspicare un ritorno al grado zero dell'architettura è senza dubbio un approccio reazionario e piacevolmente rassicurante perchè facilmente comprensibile. Ci sarà tempo ance per quello, ma per il momento godiamoci (almeno noi architetti) questa interessante biennale.
Invia nuovo commento