SPECIALE LIBRI
Il trionfo del Capitale
Negli anni '60 gettò le basi teoriche dell'operaismo, che rivoluzionò il pensiero marxista. Oggi Mario Tronti registra la sconfitta delle classi, borghesia compresa, in favore di un sistema di valori ormai inattaccabile
di Franco Milanesi
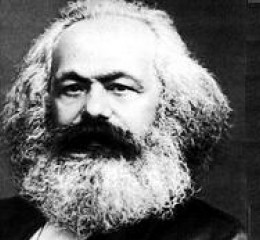
Non si esagera nel dire che Operai e capitale, opera del 1966, ha rappresentato un salto di paradigma del marxismo novecentesco. In quel libro – che, sia detto per inciso, intesseva idee innovative e radicali con uno stile di grande eleganza – Tronti capovolgeva uno degli assunti marxiani più consolidati: quello che ritiene che l’antagonismo di classe, le lotte, gli obiettivi derivino dal livello dello sviluppo che il Capitale esprime in ogni passaggio della propria storia.
L’operaismo, di cui Tronti poneva i presupposti teorici, affermava invece che era l’autonomia espressa dal conflitto operaio a costringere il capitale ad una risposta, rimodellandosi e quindi trasformandosi a partire dalle lotte del proletariato. Queste tesi non avevano nulla di astratto ma si radicavano in un intenso lavoro di conricerca, nel comune sforzo di comprensione e trasformazione col quale operai e intellettuali studiavano il funzionamento del capitale e quello del lavoro di fabbrica, che trovò accoglienza prima nei Quaderni rossi poi, in misura minore, in Classe operaia. Da queste forme di conoscenza muovevano le lotte. Originali, spontanee, radicate nel sapere operaio del funzionamento del sistema produttivo, esse sostanziavano un progetto radicale, in cui la politica e le richieste connesse al lavoro si fondevano in un’aspettativa alta, di alternativa di sistema.
L’operaismo, di cui Tronti poneva i presupposti teorici, affermava invece che era l’autonomia espressa dal conflitto operaio a costringere il capitale ad una risposta, rimodellandosi e quindi trasformandosi a partire dalle lotte del proletariato. Queste tesi non avevano nulla di astratto ma si radicavano in un intenso lavoro di conricerca, nel comune sforzo di comprensione e trasformazione col quale operai e intellettuali studiavano il funzionamento del capitale e quello del lavoro di fabbrica, che trovò accoglienza prima nei Quaderni rossi poi, in misura minore, in Classe operaia. Da queste forme di conoscenza muovevano le lotte. Originali, spontanee, radicate nel sapere operaio del funzionamento del sistema produttivo, esse sostanziavano un progetto radicale, in cui la politica e le richieste connesse al lavoro si fondevano in un’aspettativa alta, di alternativa di sistema.
Erano gli anni Sessanta: immissione di nuova forza lavoro immigrata in grandi agglomerati produttivi; scolorimento della figura dell’operaio qualificato (e spesso fidelizzato al lavoro) ed emersione dell’operaio massa; infine una montante conflittualità, quella che a partire dal 1969, l’anno dell’autunno caldo, confluirà con il movimento degli studenti nel “lungo ‘68” protrattosi per oltre un decennio.
Proprio la cosiddetta stagione dei movimenti vide Tronti su posizione defilate, scettico sulle possibilità di intaccare un sistema compatto di economia di mercato e valori borghesi che le pratiche riformiste, verso cui gran parte del movimento confluiva, finivano a suo parere per sostenere. Nei passaggi teorici successivi, scanditi da pochi, significativi volumi, emergeva il disincanto derivato dalla sconfitta, non rimediabile, dell’ “assalto al cielo”, cioè dal fallimento del progetto operaio, l’unico autentico tentativo di superamento dell’ordo borghese.
La realtà di questi ultimi decenni, da cui sono originati gli scritti di questo libro, è descritta da Tronti come un sistema coerente di democrazia liberale, capitalismo, valori; un orizzonte che si configura come senso intellettuale di massa, cioè egemonia compiuta: non tanto domino e controllo, quanto diffusione di un immaginario che agisce nel tracciare l’orizzonte delle aspettative.
Questo piccolo volume, ben curato da Pasquale Serra, raccoglie interventi che si spingono fino a ridosso della politica contemporanea. A fronte di un linguaggio politico che spesso arranca dietro alle trasfigurazioni del sociale, Tronti riesce ad illuminare in modo innovativo questa stessa realtà a partire da assunti teorici vecchi di quasi cinquant’anni. Intrecciati, per altro, con il pensiero della rivoluzione conservatrice e con quanto di più denso abbia offerto la grande cultura borghese, anch’essa sconfitta e disciolta nel grande calderone della cultura d’attualità. Ne emerge un’indicazione di metodo intellettuale, una concezione “partigiana” della conoscenza, mai neutra, mai asettica, anzi innalzata a intelligenza, a servizio di una parte sociale.
In questa prospettiva è osservata la figura di Berlinguer, incarnazione, anche corporea, di una diversità tanto politica quanto antropologica. Si comprende così sia la lettura del ’68, un “evento minore” del Novecento, sia la valutazione dell’homo religiosus come alternativa di potenzialità maggiore dell’homo democraticus, il buon riformista, protagonista illuminato della ferrea presa capitalistica e borghese sul mondo della vita.
Tags: anni sessanta, capitale, classe operaia, fabbrica, Franco Milanesi, lotte sindacali, mario tronti, marxismo, operaismo,
12 Maggio 2010
Oggetto recensito:
Mario Tronti, Non si può accettare, Ediesse 2010, euro 10
giudizio: 

(1 vote)




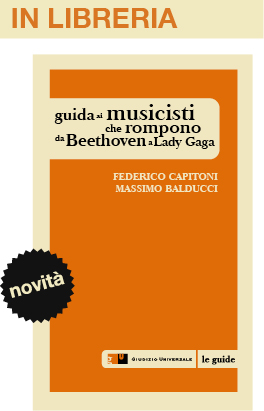



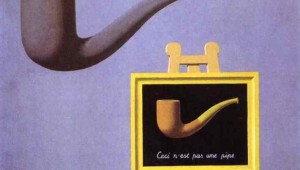



Commenti
Invia nuovo commento