I resoconti quotidiani e il bilancio finale del Festivaletteratura dal nostro inviato
di Massimo Balducci

L’illusione ottima (11 settembre)
Ed eccoci al bilancio della domenica, che è anche inevitabilmente un bilancio finale essendo stato ieri l’ultimo giorno del Festivaletteratura.
Che poi, sarà poi necessario fare un bilancio? Probabilmente no, e apparentemente è assai meno utile che segnalare l’evento in diretta o ancora meglio anticiparlo: del resto l’intero mondo della cultura segue ormai questa dinamica, e proprio questa esperienza a Mantova lo dimostra dato che l’iperattivismo dei “segnalatori” su Twitter ha prevalso enormemente sull’approfondimento di giornalisti e blogger: e si noti la soddisfazione di poter mettere “giornalisti e blogger” insieme dalla stessa parte, quella del tradizionale approfondimento, di fronte alla barbarie superficialista del duepuntozero.
Sta di fatto che le segnalazioni, alla fine, non aiutano a dare il quadro di insieme, non aiutano a cogliere il significato di un evento. Ammesso che un significato ci sia. Dobbiamo dunque chiederci: in tutto questo allegro e vitale caos di conferenze, incontri, lezioni, dibattiti, è possibile cogliere un filo conduttore, un tema che magari senza volerlo ha accomunato questa varietà di approcci? Oppure è tutto postmodernamente casuale, divertente ma in fondo fine a se stesso?
La mia panoramica è parziale: ho visto pochissimo di tutto ciò che è avvenuto, rispetto al tutto. Ma ciò vale per chiunque: nella molteplicità degli avvenimenti contemporanei, chiunque abbia assistito al Festivaletteratura lo ha fatto da una prospettiva parziale. E alla fine, quando tutti i tweet e gli appunti del momento saranno stati dimenticati, cosa ci resterà in testa?
Personalmente, dalla mia panoramica parziale, resta l’impressione che oggi sia più che mai pesante l'ossessione per il concetto di tempo: in negativo, però, ovvero per segnalarne la crisi. La crisi del tempo (vecchio tema novecentesco, ma che solo ora si esprime in tutta la sua forza) sembra essere il filo conduttore, il tema che coinvolge il filosofo, lo scrittore, il comico, l’artista, l’intellettuale in genere, e lo scienziato. Perché venerdì è stato proprio lo studioso di fisica quantistica Carlo Rovelli (“il migliore relativista sotto i 40 anni", come è stato definito) a volerci scientificamente dimostrare che “il tempo non esiste”. Mentre per tutt’altri giri, ieri Alessandro Bergonzoni arrivava alla stessa conclusione quando ha concluso - con un tipico bergonzonismo, appunto - che “il tempo è un’illusione ottima”.
Poi ripeto, la molteplicità degli stimoli e delle provocazioni a cui abbiamo assistito in questi giorni è tale da non potersi riassumere in alcun modo: quella molteplicità la troviamo intatta nei resoconti istantanei. Ma a volte bastano due estremi che si toccano, la convergenza di due opposti, per metterci sull'avviso che sta succedendo qualcosa, e cambiare più in profondità i nostri punti di riferimento. La fisica non ha più bisogno del tempo, come non ne ha più bisogno l’antropologia (uno degli ultimi libri di Marc Augé si intitola “Che fine ha fatto il futuro?”), la filosofia, l’arte, la musica. Il nontempo che prende il sopravvento sul nonluogo. E forse, per seguire il filo, dobbiamo allora passare la palla a Simon Reynolds: il critico musicale che più di tutti ha operato per demolire il concetto della temporalità nella cultura pop attuale. Certo, ci fosse stato anche lui a Mantova tutti i tasselli si sarebbero sistemati: per un curioso sfasamento temporale sarà invece in Italia questa settimana, e a Pistoia domenica 18. Riferiremo.
Qualcuno si salva da solo (10 settembre)
Oggi cominciamo dalle buone notizie: abbiamo risolto i problemi tecnici per la diretta da Mantova, o meglio li abbiamo bellamente aggirati dirottandoci su Twitter. E in fondo è giusto così, utilizzare Facebook era davvero troppo plebeo per un evento chic come il Festivaletteratura: grazie al provvidenziale disguido di ieri ci siamo così adeguati, perché qui è tutto un twittare, e c’è perfino una sorta di cabina in piazza con l’icona del celebre uccellino e l’imperativo “twitta qui”. Come dire, non ci sono scuse. Anche nell’eventualità che tu non abbia uno smartphone, un portatile, una connessione, puoi twittare: e quindi, devi.
Già, ma cosa c’è da twittare? In effetti, parecchia roba. E siccome il programma del festival offre come al solito una sovrabbondanza di appuntamenti tale da disorientare chiunque, alla fine il termometro migliore per individuare gli appuntamenti importanti è proprio vedere quanti tweet vi vengono dedicati: ottimo esempio, peraltro, di come il duepuntozero sia un magnifico esempio di conformismo “dal basso”.
E io senza volerlo mi conformizzo completamente, visto che dopo l’incontro con lo scrittore libico Hisham Matar, punto a colpo sicuro verso il cortile del Conservatorio, dove ci attendono Riccardo Bertoncelli e Greil Marcus: il primo magari più noto al pubblico qui in Italia, ma la vera attrazione è ovviamente il secondo, teorico della “Old wierd America” e credo il massimo esperto mondiale di Bob Dylan. Il quale infatti, come Bertoncelli nota fin dall’esordio, è il “convitato di pietra” di questo evento. La prima mezz’ora scorre via abbastanza inutile, con abbondanti dosi di aneddotica, e inizio a spazientirmi: mi distraggo un po’ solo seguendo (via Twitter, manco a dirlo) Wu Ming e lo stagista Einaudi che polemizzano sulla discografia di mister Zimmerman.
Poi però Bertoncelli e Marcus si ricordano di essere i critici musicali che sono, ed il discorso si fa interessante. Per la cronaca più dettagliata di quanto detto da Marcus vi rimando alla diretta di stamattina, qui voglio solo citare un paio di spunti che meriterebbero una riflessione più approfondita. Il primo spunto, anzi, la prima “regola”, è che “fare critica musicale significa analizzare le tue reazioni alla musica, non descrivere la musica stessa”. La seconda riguarda l’inutilità dell’intervistare gli artisti, che Marcus motiva (oltre che con la sua personale esperienza) rivendicando la necessità di essere un po’ arroganti: “come critico sono più interessato a ciò che dico io, rispetto a ciò che dice l’artista!”. Anche perché, come nel caso di Dylan, l’opinione dell’artista finirebbe per prendersi tutto lo spazio e soffocare la tua. Come dire, il critico non deve mai avvicinarsi troppo all’oggetto del suo interesse.
Quando ho scritto all’ufficio stampa del Festivaletteratura per chiedere l’accredito, ho promesso però che non avrei parlato solo di metacritica ma anche di aspetti più terreni: per esempio, cosa mangiare quando si è qui a Mantova? Ebbene oggi posso finalmente rispondere alla domanda, dopo essermi abbuffato di maccheroni al torchio con stracotto alla trattoria dei “Due Cavallini”. Rimango spiazzato solo dal vino rosso freddo, ma boh, si vede che da queste parti usa così.
Fine dello spazio pubblicitario, fine del pranzo, inizio di un pomeriggio non troppo ricco di soddisfazioni. Del resto forse dovevo aspettarmelo che andare ad un incontro dal titolo “Se un matematico rilegge Calvino” non era una grande idea: e infatti, si rivela una mattonata micidiale. Allora passo da un estremo all’altro, e mi dirigo al Palazzo Ducale dove sta per arrivare Margaret Mazzantini. La coda chilometrica dei poveretti che restano ore sotto il sole per poter vedere Margaret Mazzantini è uno spettacolo di impareggiabile masochismo, e ho troppo rispetto della sofferenza umana per infierire e dire qualcosa sui gusti del pubblico. In fondo si sono già puniti da soli. E del resto mi punisco anch’io perché assisto a ben dieci minuti dell’incontro con Margaret Mazzantini, che parla di amori che finiscono, che crollano per tante piccole cose, tipo che senti lo smog in strada, e respirare lo smog ti fa sentire sporco, allora capisci che la vita fa schifo e allora non riesci più neanche ad amare. Ah, Margaret, sono davvero profondi questi pensieri, devo ammettere che mi sto già deprimendo, anzi sto cercando di strozzarmi con il cordellino dell’accredito: per smettere di soffrire ho una sola possibilità, scappare a gambe levate, salvarmi da solo, almeno io. Giusto in tempo per sottrarmi al suicidio di massa che sta per sopraggiungere, e che ovviamente avverrà tramite cospicua inalazione di smog (o lettura di estratti dal libro, a scelta).
A risollevare gli animi arriva lui, l’idolo delle folle, Nicola Gratteri: ecco, Gratteri è uno che per carità, grandissimo magistrato, ma sono convinto che in quel ruolo è sprecato, uno così dovrebbe fare il guru, il profeta, il papa, magari straniero. Certo mica è l’unico intelligente, anche Saviano per dire è intelligente, ma vuoi mettere, un duro come questo dove lo trovi. Con la sua filosofia di vita che sembra quella di un Clint Eastwood dopo avere letto Adorno, anche oggi Gratteri torna sui suoi pezzi forti: su come sarebbe semplice ridurre le spese per la giustizia, se non fosse che la politica per prima è interessata a che la giustizia funzioni male; sulla necessità di resistere all’omologazione culturale; sullo stato attuale della lotta alla mafia, che è di “pareggio”; sulle intercettazioni che sono lo strumento di indagine più economico e più garantista in assoluto; sull’importanza decisiva della scuola, anch’essa però sgradita ai governi perché se un popolo è colto ed istruito poi si ribella. Ma la riflessione che più mi colpisce è questa: “La mafia è una minoranza. Ma nel nostro sistema politico, basta controllare il 15% dei voti per essere determinanti”.
E con questo subliminale accostamento tra Casini e Totò Riina, possiamo per stasera tornarcene a casa, poco tranquilli.
Cominciamo bene (9 settembre)
Tanto per cominciare, l’inviato da Mantova assegna quattro ombrelli a sé medesimo per avere clamorosamente ciccato la promessa “diretta su Facebook”. In effetti l’inviato (che sarei sempre io) ha fatto la sua bella diretta minuto per minuto o quasi, o meglio ha creduto di farla dato che di essa non vi è traccia sulla nostra pagina di Facebook. E a questo punto mi chiedo, su quale diavolo di bacheca siano finiti: forse su quella di Sandro Bondi, che pare essere il fantasma che aleggia su Mantova in questi giorni. Citarlo è praticamente obbligatorio dopo il caso Mondadori; e non importa se a sproposito, come ha fatto oggi per esempio Serena Dandini, che si è autopresentata così: “Doveva venire l’ex ministro Bondi a presentare Tea, ma l’hanno chiamato a Mondadori e quindi ci sono io”.
Risate, applausi, sorrisi di intesa. Che bello essere qui nel posto più radicalchic del momento, poi certo ci sono tanti modi di essere radicalchic e quello della Dandini personalmente mi fa scattare una reazione allergica. Alla quale comunque resisto, dato che la “Tea” di cui sopra è Tea Obreht, vale a dire uno dei motivi per cui sono a Mantova: il suo libro lo sto ancora leggendo e non posso giudicare, ma del resto l’hype che la circonda, gli accostamenti esorbitanti a Bulgakov e Garcìa Marquez, i premi già vinti alla veneranda età di 25 anni, renderanno comunque impossibile giudicarla serenamente per un bel po’ di tempo. E ciò dimostra, ancora una volta, che l’hype è il male.
Devo aggiungere che questa specie di “Parla con me” dal vivo non aggiunge grandi lumi su questa autrice, alla quale comunque esprimo la mia solidarietà per avere sopportato un’ora di domande del tipo: “Perché nella tua storia non ci sono i vampiri? Sappiamo che i vampiri vengono dai Balcani!” (è di origini bosniache). Provo ad immaginarmi se per assurdo io fossi andato a presentare un mio romanzo al festival della letteratura di Belgrado, e mi avessero chiesto: “Ma perché in questa storia non c’è la pizza? Sappiamo che la pizza è italiana, tutti in Italia mangiano la pizza!”. E io a dire che sì, effettivamente noi italiani siamo dei grandi mangiatori di pizza e non pensiamo ad altro, e nel sequel emergerà la passione del protagonista per la quattro stagioni.
In generale, a parte l'incresciosa vicenda di Facebook, non posso mentire dicendo di avere assistito a chissà quante cose oggi, avendo messo piede in città a pomeriggio inoltrato. Non ho fatto che incontrare gente che andava a vedere “quelli della casta”, non nel senso di Scilipoti e Bondi ma di Rizzo e Stella, dei quali non mi ero nemmeno accorto guardando il programma: devo averli censurati inconsciamente, e non certo perché abbia qualcosa contro di loro ma perché effettivamente non capisco bene cosa ci facciano qui. Sarà che li ho appena visti a casa di Telese e Costamagna, e qui credo sia più utile fare altro.
Mi sono precipitato invece alla lezione di musica tenuta da Giovanni Bietti al Conservatorio, e pur essendomene visto solo un pezzo, credo sia stato l’appuntamento migliore della giornata. Ammiro molto come Bietti riesca a parlare di un argomento certo vecchio ma sempre molto ostico, come il rapporto tra testo poetico e composizione musicale, senza annoiare. Sarà che standosene al pianoforte, ed intervallando la parte “frontale” della sua esposizione con degli esempi (anche cantati) al volo, si crea più facilmente un contatto con il pubblico.
Ed analizzando esempi da Verdi, Mozart, Monteverdi, Haendel, si mostrano i mille modi possibili con cui un musicista può “aderire” con la musica al testo: ad esempio, su come si può rendere l’intonazione di una frase interrogativa (vedi le Nozze di Figaro), o come si può rendere l’immagine dell’innalzamento (vedi il Messiah di Haendel). E poi i Madrigali di Monteverdi, a proposito dei quali l’oratore si è quasi adirato per la loro assenza dal repertorio attuale: “è una vergogna!”. Aggiungendo che “il Combattimento di Tancredi e Clorinda è uno dei brani più sperimentali nell’intera storia della musica”.
E sarei rimasto fino in fondo, giuro, ma alle 18 c’era Carlo Boccadoro in piazza che faceva la sua lezione su Bob Dylan con tanto di schemi alla lavagna. Lezione dalla quale è uscito confermato ciò che da queste parti sosteniamo da tempo, ovvero che l’autore di Like a rolling stone è infinitamente più noioso e retrogrado di Monteverdi stesso.
Prima di andare via, stasera ho fatto in tempo a sentire uno scienziato esperto in una branca specifica di cui non ricordo il nome, che partiva da questo assunto: “il tempo non esiste”. Ve lo riporto come tale, io purtroppo non ho potuto assistere alla dimostrazione perché altrimenti non avrei avuto il tempo di prendere l’ultimo treno per Bologna.
Tags: festivaletteratura, mantova, Massimo Balducci,




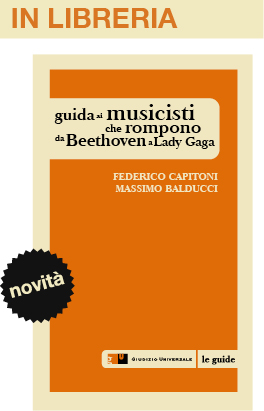



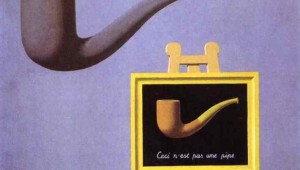



Commenti
Invia nuovo commento