Questo è l'uomo, niente di più, secondo un doloroso romanzo di Hilsenrath, Il nazista e il barbiere
di Dario De Marco
In una meravigliosa parabola di J.L. Borges, Caino e Abele si incontrano dopo la morte di Abele. Si siedono a mangiare, in silenzio; a un certo punto Caino alza lo sguardo e, vedendo con terrore la ferita mortale sulla fronte del fratello, gli chiede perdono. La risposta di Abele è sublime: “Tu hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo, siamo di nuovo qui insieme, come prima”.
Tema simile, con taglio diverso, ha questo Il nazista e il barbiere di Edgar Hilsenrath. Per lui si è parlato di nuovo romanzo picaresco e di humour nero. Sicuramente vero, ma c’è dell’altro. Le prime 50 pagine sbalordiscono: all’inizio assistiamo allo stupro di un bambino di sette mesi, messo in atto dal patrigno davanti agli occhi della madre. E così di seguito, avvenimenti crudeli e sordidi sono raccontati con assoluta nonchalance: più che humour nero, verrebbe da usare l’ossimoro “minimalismo pulp”. Questo originalissimo modo di narrare serve a farci entrare nelle situazioni più assurde senza che le si percepisca come tali: quando, ormai a pag. 110, il protagonista trova, in un lurido scantinato della Germania postbellica, la moglie di un suo commilitone morto (“scotennato e sbudellato”), e fa sesso con questa donna che ha una gamba di legno, a due metri dal cadavere di un vecchio militare americano con cui la Frau era andata a letto il giorno prima in cambio di qualche scatoletta di carne, ebbene i personaggi vivono questa scena in modo perfettamente normale, e anche noi la leggiamo così. Lo stile è funzionale alla visione del mondo: non la banalità del Male, ma la sua normalità; cioè il Male come norma, necessità.
Quel bambino violentato, Max Schulz, diventa amico dell’ebreo Itzig Finkelstein, ed è con lui apprendista barbiere nel salone Finkelstein; poi si fa nazista, più per caso che per frustrazione, e in un campo di sterminio polacco uccide l’amico e tutta la famiglia; infine per salvare la pelle si fa circoncidere e tatuare un numero di Auschwitz, assume il nome di Itzig Finkelstein, è sionista fanatico e partecipa alla nascita d’Israele. Non dimentica ciò che ha fatto, ma non cerca giustificazioni per il passato, né per il presente.
Non dev’essere stato facile, per l’ebreo Hilsenrath, mettersi nei panni dell’ariano Max Schulz che a sua volta cerca di calarsi nella persona dell’ebreo Itzig Finkelstein. Il gioco di specchi potrebbe continuare all’infinito. Ma è inutile moltiplicare le entità: ne bastano due. Infatti questo discorso ci avvicina al cuore del problema, raffigurabile attraverso un dualismo, una dicotomia. Non già il dualismo Bene-Male: troppo ovvio, questo, troppo ottocentesco come dilemma. Il rapporto Bene-Male c’è, ma è strumentale e, come nell’apologo di Borges, serve da trampolino per lanciarsi in un altro dualismo: il rapporto Io-Tu, il discorso sull’identità, caratteristico della grande letteratura del ’900. Può essere formulato con semplici domande: chi sono Io? e chi sei Tu? Perché Io sono così e Tu sei cosà? E soprattutto, se Io fossi te e Tu fossi me, le cose sarebbero diverse? o non, piuttosto, assolutamente le stesse?
La risposta che sembra suggerirci Hilsenrath è sconfortante: le stesse, assolutamente. Ovvero: l’uomo è una scatola vuota, che può essere dipinta all’esterno con qualsivoglia colore, anche più di una volta, ma mai riempita all’interno con qualcosa. Sì, questo è un uomo, viene da parafrasare. Un uomo è capace di uccidere migliaia di ebrei, come di vivere e morire assistendo i lebbrosi; un uomo è capace di inventare la bomba atomica, come la teoria della relatività. Più modestamente, un uomo è capace di partecipare al Grande Fratello, come di scrivere un libro notevole quale Il nazista e il barbiere.
Tags: caino e abele, Dario De Marco, ebrei, edgar hilsenrath, giorno della memoria, il male, il nazista e il barbiere, israele,
EDGAR HILSENRATH, IL NAZISTA E IL BARBIERE, MARCOS Y MARCOS 2010, EURO 16
Due traduzioni: la prima edizione italiana (Mondadori, 1973) era tradotta dall’inglese a opera di Maria Luisa Bocchino; l’attuale è confrontata con l’originale tedesco da M.L. Cortaldo
Due versioni: il libro ebbe difficoltà a uscire in Germania, dove fu pubblicato solo nel 1976, con un finale edulcorato
Due frasi: “Avete idea di come si fucilano trentamila ebrei in una foresta? E avete idea di che effetto può fare a uno che non fuma? Fu così che imparai a fumare” (pag. 71). “Una bella pioggerella non avrebbe fatto male. Ma evidentemente Dio non può farlo, dato che in questa parte di oceano non piove mai, durante l’estate. Deve aver qualcosa a che fare col clima” (pag. 247)
Due romanzi sul nazismo, agli antipodi nel tempo: Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947; Imre Kertész, Liquidazione, 2005
Due saggi sul nazismo, agli antipodi nelle idee: Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo (1951, dove il nazismo è il Male assoluto); Hannah Arendt, La banalità del male (1963)
Due giudizi su Hilsenrath: “I primi capitoli fanno male. Più avanti si capisce il perché: non fa malissimo, ciò che in effetti è accaduto?” (Heinrich Böll); “Se potessi, non scriverei così. Mi sento in colpa per essere sopravvissuto” (Edgar Hilsenrath, non sfuggendo all’ovvio)
Due soli: solo? Grande libro, gli manca il guizzo del capolavoro, e nella parte centrale ha qualche lungaggine di troppo





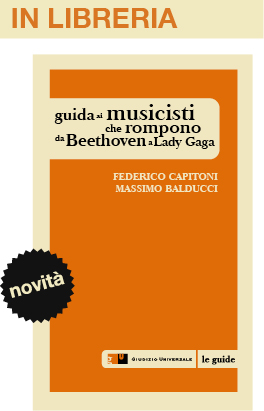



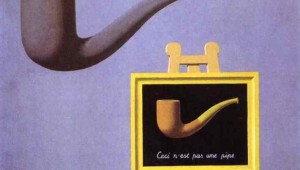



Commenti
Invia nuovo commento